di Damiano Palano
Questa recensione al volume di Franco Milanesi, Nel Novecento. Storia, teoria, politica nel pensiero di Mario Tronti (Mimesis, Milano, 2014) è apparso su "Tysm magazine" il 15 ottobre 2014. Il libro di Milanesi sarà presentato a Milano, presso la Casa della Cultura (Via Borgogna 3), giovedì 20 novembre, alle ore 17.30. Oltre all'autore, parteciperà alla discussione Carlo Formenti.
Nel gennaio 2003, assistendo ai funerali di Gianni
Agnelli, Marco Revelli si immergeva tra la folla che sfilava dinanzi al feretro
dell’«Avvocato» per ricercare le orme di quella che – ancora pochi anni prima –
era stata la «capitale del lavoro», e forse anche l’unica vera «città-fabbrica»
italiana. In realtà ben poco era rimasto dei miti dell’industrialismo
novecentesco. Il Lingotto, in cui era ospitata la camera ardente, non mostrava
più nulla della sua vecchia natura di tempio modernista della produzione. Tra i
volti disciplinatamente in fila per rendere il proprio omaggio alla salma, gli
operai non erano neppure riconoscibili. E anche il rituale funebre finiva col sembrare
abissalmente distante dalla geometria dell’ordine della Fabbrica, assumendo
piuttosto i contorni di una manifestazione tardo-ottocentesca. «Non è stato un
funerale ‘industriale’», scriveva Revelli, ma un rito «d’ancien régime», «che ha scoperto, sotto la patina del secolo
industriale, una Torino di longue durée,
radicalmente monarchica nel proprio immaginario collettivo, nella gestualità,
nei linguaggi simbolici, nella struttura delle fedeltà e dei comportamenti,
popolana più che popolare, cortigiana più che disciplinata». Dinanzi al
feretro, veniva così a riemergere un immaginario pre-industriale, tutto
costruito su una polarità elementare: «il corpo del sovrano e la folla informe
dei ‘suoi’ sudditi», «la ‘persona’ nella quale il corpo sociale si rappresenta
e riconosce, e la massa informe di chi senza quel simbolo non sarebbe». Ma dei
soggetti politici ed economici che avevano segnato il Novecento non sembrava
più neppure vagamente visibile una traccia sbiadita: «Mancava, clamorosamente,
fragorosamente, direi, l’Impresa […]. Mancavano le Fabbriche, i loro simboli,
le loro insegne, i loro nomi. Mancavano gli Operai, le figure del Lavoro,
riconoscibili, visibili fino a pochi anni fa. Mancava […] il Lavoro. Si vedeva
solo il Potere – nella sua forma tradizionale di struttura di dipendenza
personale, di essenza della ‘sovranità’ -, ma il Lavoro che è la struttura in
cui nella modernità il potere s’innerva, si fa pratica e conflitto collettivi,
e infine Produzione, quello non si vedeva, come scomposto e dissolto
nell’aggregazione casuale della folla, nei volti indistinti della ‘gente’» (M.
Revelli, La cerimonia degli addii. Il
funerale di Gianni Agnelli e la fine dell’industrialismo, in Id., Controcanto, Chiarelettere, Milano,
2010, pp. 207-208).

Non era la prima volta che Revelli si imbatteva
nell’«aggregazione casuale della folla», nei «volti indistinti della ‘gente’»,
in quel residuo pre-moderno, in cui la vocazione industrialista di Torino
sembrava totalmente sommersa dalla sua soggezione sabauda a un potere
monarchico. Più di trent’anni prima, seguendo in presa diretta – come
‘intellettuale militante’ – i trentacinque giorni dell’occupazione operaia di
Mirafiori, aveva intravisto nella «marcia di quarantamila», nei volti
compassati dei quadri di fabbrica che il 14 ottobre 1980 sfilarono per le vie
di Torino chiedendo la rimozione dei picchetti, la nitida anticipazione di un
mutamento d’epoca. «Venivano giù a branco, uniformi e grigi come il muro dei
reparti», aveva scritto in una cronaca per alcuni aspetti persino profetica,
«con un rumore sordo di ciotoli che rotolano, di bisbigli trattenuti, di passi
strascicati, quel rumore che esce dalle folle occasionali in attesa, o dai
funerali… riempivano lentamente il centro della città, senza simboli, colori, bandiere»
(M. Revelli, Gli operai di Torino e gli
«altri», in «Primo maggio», n. 14, 1980-1981, p. 8). Ma se quei quadri
erano ancora «un pezzo di fabbrica trasferito in città», e dunque
«un’espressione soggettiva del lavoro senza soggettività», la schiera di volti
anonimi che rendevano il proprio rispettoso omaggio all’«Avvocato» parevano
ormai avere smarrito ogni legame con il simbolismo novecentesco, con la
religione produttivista della Fabbrica, con i suoi ritmi e con la sua
disciplina, oltre che naturalmente con i suoi conflitti.
La scoperta nella camera ardente del Lingotto di una
sorprendente folla ottocentesca evidentemente equivaleva per Revelli a una
conferma della fine dell’industrialismo. La «folla» anonima, disciplinata,
priva di identità, era infatti l’esatto opposto rispetto alla «classe»
novecentesca, cresciuta dentro la geometria della fabbrica e dentro la
mitologia produttivista del Novecento. E per questo i funerali di Gianni
Agnelli suonavano come l’ennesima conferma della necessità di archiviare il
«secolo breve», con le sue ideologie, i suoi conflitti, i suoi orrori e
naturalmente i sogni prometeici coltivati dal movimento operaio. Con Oltre il Novecento, pubblicato proprio
all’inizio del nuovo secolo, Revelli si era infatti già accomiatato – in
termini peraltro piuttosto radicali – da quell’immaginario, e in particolare da
quella versione che in Italia ne aveva fornito l’«operaismo». Per Revelli – che
aveva adottato per decenni la prospettiva operaista, seppure in una variante
specifica – era ormai divenuto indispensabile abbandonare la mitologia
dell’industrialismo: una mitologia che aveva condotto il movimento operaio ad
adottare la medesima visione produttivista della fabbrica, e che aveva indotto
a concepire come una «macchina» efficiente, come uno strumento di lotta
politica, quel partito che invece era ben presto diventato fine a se stesso.
Non tutti gli epigoni dell’operaismo degli anni Sessanta e Settanta avevano
imboccato questa medesima strada. In termini quasi paradigmatici la «moltitudine»
sarebbe infatti divenuta per molti una sorta di erede post-moderno della
vecchia «classe», un erede dai contorni ancora sfuggenti eppure capace di
raccogliere il testimone abbandonato dalle figure conflittuali protagoniste del
Novecento. Se in questo senso Empire di
Michael Hardt e Antonio Negri costituiva quasi una sorta di antitesi al
discorso di Oltre il Novecento, fra
gli eredi della riflessione operaista non mancava anche un’altra opzione, che
si distingueva quantomeno per un radicale pessimismo. E a indicare una simile
prospettiva era proprio Mario Tronti, che a buon diritto – con Operai e capitale – può essere considerato come il fondatore di questo filone di
pensiero, l’espressione forse principale di quella che è stata recentemente
definita come la Italian Theory.

Prima ancora che il Ventesimo secolo si chiudesse,
Tronti aveva infatti già solennemente e malinconicamente riconosciuto che –
insieme alla parabola del movimento operaio – si era consumata anche la fine
della politica moderna. Proprio nelle pagine introduttive della Politica al tramonto aveva scritto: «A
guardarlo dalla fine del novecento, il tempo della politica che hai
attraversato ti appare come un fallimento storico. Non erano troppo altre le
pretese, erano inadeguati gli strumenti, povere le idee, deboli i soggetti,
mediocri i protagonisti. E la storia, a un certo punto, non c’era più: solo
cronaca. Niente epoca: giorni, e poi ancora giorni. Il miserabilismo
dell’avversario ha chiuso il cerchio. Non c’è grande politica senza la
grandezza del tuo avversario» (M. Tronti, La
politica al tramonto, Einaudi, Torino, 1998, p. XI). Dopo più di quindici
anni – nel corso dei quali, nelle riflessioni di Tronti, sono peraltro
affiorati talvolta piccoli segnali di ottimismo – i toni del vecchio maestro
tornano oggi a diventare cupi. In una lunga intervista con Antonio Gnoli,
definendosi uno «sconfitto» - ma non un «vinto» - Tronti ha rivendicato di
appartenere a un’epoca ormai irrimediabilmente conclusa: «Sono un uomo fuori da
questo tempo. Ho sempre condiviso la tesi del vecchio Hegel che un uomo
somiglia più al proprio tempo che al proprio padre» (A. Gnoli, Mario Tronti: «Sono uno sconfitto, non un
vinto. Abbiamo perso la guerra del ‘900», in «la Repubblica», 28 settembre
2014, pp. 52-53).
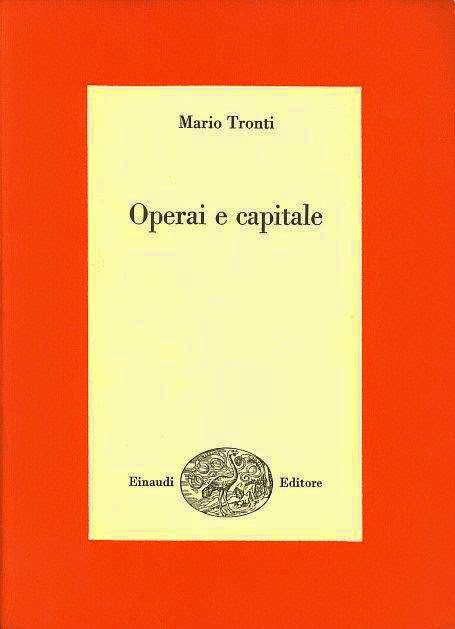
Un contributo importante per ricostruire
l’itinerario di uno dei più originali intellettuali della storia repubblicana
viene ora dal volume di Franco Milanesi, Nel
Novecento. Storia, teoria, politica nel pensiero di Mario Tronti (Mimesis,
Milano, pp. 297, euro 22.00). Il lavoro di Milanesi può essere in qualche modo
letto come una sorta di ‘biografia politico-filosofica’ dell’autore di Operai e capitale, dal momento che segue
le diverse sequenze di sviluppo del pensiero di Tronti in relazione agli snodi
politici della sua esperienza. Come avviene ormai per pochi pensatori
contemporanei, nella ricerca di Tronti è davvero difficile individuare una
riflessione teorica che non sia anche sempre una riflessione ‘politica’, ossia
una riflessione che – magari cripticamente – intende il pensiero come strumento
di cui valersi dentro un conflitto. E così è anche inevitabile che le grandi
scansioni della metà del Novecento trovino ben più di un vago riflesso dentro
le stagioni della ricerca trontiana. Nei primi scritti su Gramsci, si può
ravvisare infatti l’eco del 1956 e della crisi che l’invasione sovietica
dell’Ungheria produce sul Pci, mentre nella stagione operaista – in realtà
brevissima per Tronti, dal momento che in fondo si consuma nell’arco dei pochi
anni che vanno dal 1961 al 1967 (quando esplode il Sessantotto studentesco
Tronti sembra ormai guardare verso altri orizzonti teorici e organizzativi
rispetto a quelli delineati in Operai e
capitale) – si colgono per intero le ambivalenze del boom e dei primi governi di centro-sinistra.

Nelle fasi successive
– segnate teoricamente dalla ‘scoperta’ dell’«autonomia del politico» - si
riconoscono invece le nuove difficoltà che incontra il Partito comunista dopo
l’Autunno caldo e poi durante la fase del «compromesso storico». Infine,
nell’Ottantanove, nella scomparsa del Pci, nella disfatta del movimento
operaio, si ritrova la svolta che induce Tronti a prendere atto del tramonto
della politica moderna. Ed è forse in corrispondenza di questo passaggio –
quando gli scritti di Tronti diventano spesso ermetici, allusivi, talvolta
oscuri, anche per palesare anche formalmente l’estraneità alla nuova stagione –
che il lavoro di Milanesi diventa più complesso, quantomeno perché deve tentare
di ricomporre in un mosaico unitario i frammenti di un discorso interrotto. Un
discorso che ama spiazzare il lettore, con provocazioni intellettuali,
esplorazioni fra i classici del pensiero conservatore, sperimentazioni con il
linguaggio della spiritualità: operazioni di cui spesso al lettore finisce per
sfuggire la cifra politica, che invece continua incessantemente a segnare la
riflessione trontiana.
Senza dubbio il lavoro di Milanesi rappresenterà da
questo momento un punto di riferimento per chiunque voglia accostarsi al
pensiero di Tronti, anche perché – a differenza di altri scritti più o meno
organici apparsi sinora – si confronta con l’intera riflessione
dell’intellettuale romano, e non solo con la sua fase «operaista», peraltro
ancora oggi al centro dell’attenzione di molti studiosi neo-marxisti un po’ in
tutto il mondo. A contrassegnare e a rendere originale la lettura di Milanesi è
infatti, semmai, proprio l’interesse che viene rivolto all’indagine trontiana
sull’«autonomia del politico»: un’indagine che si svolge soprattutto a partire dagli
anni Settanta, ma che, in qualche misura – e qui Milanesi tocca un punto spesso
sottovalutato – percorre l’intera ricerca di Tronti. D’altronde, il nodo
dell’organizzazione politica affiora già nel dibattito degli anni Sessanta. In
questa discussione – che sancisce peraltro il passaggio dai «Quaderni rossi» a
«Classe operaia» - Milanesi osserva infatti che la «sensazione è che manchi
sempre un passaggio, manchi in fondo proprio quella politica ‘messa in forma’
di organizzazione» (p. 59).

Ma per Tronti, secondo la lettura di Milanesi, già
in questa stagione «la politicità della lotta non può che svilupparsi dentro un
discorso complessivo sulle forme e le strutture di potenziamento e di indirizzo
dell’azione di classe» (p. 61). È d’altronde su queste basi che Tronti chiude
l’esperienza di «Classe operaia» e torna nell’alveo del Partito Comunista, dal
quale peraltro non è mai veramente uscito, dal momento che probabilmente ha
sempre inteso la ‘protesta operaista’ come un’operazione radicale di rinnovamento
della cultura e del gruppo dirigente di quel partito. Ma è anche su queste basi
che prende a confrontarsi con più intensità con il tema dell’«autonomia del
politico», approssimato in realtà per passi successivi. Al centro di molte
feroci discussioni, quelle ipotesi sono spesso accolte dai critici vicini alla
sinistra extra-parlamentare come una sorta di legittimazione della strategia
del «compresso storico», anche se – come nota Milanesi – si tratta piuttosto di
un ragionamento che procede in una direzione differente (pp. 182-183). Si
tratta, cioè, di «usare il partito per superare la debolezza politica delle
masse e attaccare là dove l’avversario mostra “un difetto di
razionalizzazione”, cioè sul piano istituzionale, che appare insufficiente sia
sul versante del governo sia su quello amministrativo» (p. 139). Anche per il
clima del periodo, Tronti in realtà non esplicita però le proprie riserve sul
progetto del compromesso storico nel corso degli anni Settanta, ma solo quando
l’esperienza dei governi di solidarietà nazionale si è esaurita, sul finire del
decennio. Al tempo stesso, una simile critica non si traduce comunque in un
attacco alla linea seguita da Berlinguer. Anzi la figura del segretario tende a
diventare negli anni Ottanta per Tronti – specialmente dopo la sua prematura
scomparsa – una sorta di simbolo antropologico di una possibile «alternativa»:
come scrive in questo senso Milanesi, «la figura di Enrico Berlinguer
rappresenta l’ultimo tentativo di elaborazione di un’alternativa al sistema e obbliga
ad aprire una riflessione sul significato del rapporto tra il comunismo e
l’“essere comunisti”, secondo una curvatura antropologica del pensiero politico
che a partire dagli anni Ottanta sempre più frequentemente troviamo svolta
nelle pagine di Tronti» (p. 187).

In effetti la dimensione antropologica
diventa a partire dagli anni Novanta sempre più importante per Tronti, nel
senso che è l’«ultimo uomo», l’uomo medio, l’homo oeconomicus, il protagonista di quella democrazia di massa che
segna la fine della politica moderna. «Le masse sono diventate sempre più la
massa, cioè un insieme di individui senza classe, incapaci come tale di
autorganizzazione politica», diceva Tronti in un’intervista di alcuni anni
fa. E proprio queste masse manipolabili
– così simili in fondo a quelle che Revelli riconosceva in fila alla camera
ardente del Lingotto – segnano il tramonto della politica.
In realtà, nella lettura di Milanesi la posizione di
Tronti fa trapelare comunque una possibilità residua per la politica. «La ‘talpa’
del pensiero trontiano», scrive infatti Milanesi verso le pagine conclusive,
«senza lasciare la presa, continua il suo scavo ‘dentro e contro’ e torna a
pensare le radici del politico alla ricerca di una sua fondazione» (p. 243). Il
pensatore romano, secondo Milanesi, «si muove lungo una via di fuga dal secolo
ventesimo che inverte il senso storico-teorico di posizioni che, molto critiche
verso quella storia, finiscono tuttavia per riproporne concettualità e
struttura. Insiste invece sulla necessità di accogliere pienamente il senso del
Novecento come base per un rilancio di politica che sia, in gran parte, altra rispetto alle espressioni del
secolo trascorso. Ciò significa tornare a pensare e fare rigettando tanto la
dialettica dell’immediatismo, che ritiene che il capitale nel suo sviluppo
produca necessariamente il soggetto destinato a superarlo, quanto le culture
dell’esodo o quelle che riducono la lotta al capitalismo al tentativo di
controllo democratico del mercato. Modi, in fondo, tipicamente novecenteschi,
evidentemente deboli rispetto alla potenza del tecno-capitalismo» (p. 276).

La
linea di ricostruzione si muove tanto sul terreno culturale, quanto sul terreno
strettamente organizzativo, ed è d’altronde proprio su questi due piani che si
muove forse da sempre il lavoro trontiano sul politico, e che rende la sua
opera – come scrive Milanesi – un «classico del pensiero politico novecentesco,
uno dei suoi punti più alti», anche se «non è mai solo questo». «La forza dei
suoi apparati argomentativi, il linguaggio incisivo ed evocativo, l’originalità
delle prospettive analitiche vanno intesi come espressioni di un dispositivo
politico che rigetta, pur mantenendo una propria cifra di levità formale,
l’autonomia del teorico e la tendenza alla teoria generale» (p. 279).
Le traiettorie di questa fuoriuscita dal XX secolo
rimangono però, per molti versi, come uno sviluppo di ciò che la politica del
Novecento aveva offerto, e in particolare di ciò che per Tronti era stata la
scoperta della parzialità. «Ci vuole un punto di vista, da cui guardare il
mondo, e la vita», «ci vuole una parte di mondo e di vita a cui ascrivere il
proprio pensiero», ha scritto nel suo ultimo volume Per la critica del presente (Ediesse, Roma, 2013, p. 15). Ma ha
anche ricordato: «Oggi, per la storia che il movimento operaio ci ha lasciato
in eredità, la tua parte te la devi andare a cercare con intelligenza,
paziente, con passione, pensante, strappandola quasi giorno per giorno alla
narrazione che l’ha sepolta, bucando il velo delle idee dominanti che l’hanno
data per morta, e poi facendola scorgere da lontano, con la visione, facendola
toccare con mano da vicino, con il realismo, sempre consapevole di star e di
operare tra le sbarre di una gabbia d’acciaio» (p. 15). Per molti versi proprio
la ricerca di un simile punto di vista – che ovviamente non può coincidere né
con il punto di vista di un singolo, né con l’evocazione di un interesse
«generale» - accompagna l’intero percorso teorico di Tronti fin dai suoi primi
passi, scandendone le diverse stagioni. È d’altronde la rivendicazione di
quella stessa parzialità che conduce oggi il filosofo a evocare quell’«oltre»
che affiora problematicamente dalle pagine più recenti. Ed è forse a partire
dalla centralità di quel punto di vista che diventa possibile ricostruire, o
quantomeno immaginare, le linee di sviluppo di quell’antico progetto, più volte
annunciato e ogni volta accantonato, celato da Tronti sotto il titolo
affascinante, oltre che del tutto inattuale, Per la critica della democrazia politica.

Proprio nelle pagine conclusive di Per la critica del presente, in un
saggio inedito intitolato evocativamente La
sinistra e l’oltre, Tronti ragiona sulle possibilità di attribuire un nuovo
significato alla parola «sinistra»: «si può andare oltre la sinistra, senza
tornare indietro dalle conquiste con essa ottenute, si può ampliare il suo
campo senza perdere il suo senso?» (pp. 117-118). La risposta a quella domanda
passa per Tronti innanzitutto dalla rinobilitazione dell’idea stessa della politica
come progetto di trasformazione, un’idea che invece gli ultimi trent’anni hanno
del tutto demolito. «L’idea del ‘nuovo che avanza’, fatta propria ed esercitata
dalle più tradizionali forze conservatrici dello stato di cose presente»,
scrive, «è la ‘novità’ vera intervenuta, a breve, storicamente, nel panorama
politico contemporaneo» (p. 121). Contro questa operazione di squalificazione
della politica, indica dunque come indispensabile il recupero di una visione di
lungo periodo: «Va ricostruito un orizzonte, c’è bisogno più che di una
narrazione di una visione, l’assunzione di un compito appunto storico. Noi che
abbiamo detto di venire da lontano e di volere andare molto lontano, non
possiamo offrire a chi vede impegnarsi la sola capacità di misurare meglio di
altri la contabilità di piccoli passi quotidiani. Da giovanissimi, di quella
che era un’epoca, i nostri padri ci insegnavano a occuparci della fontanella,
ma come passo per arrivare a costruire il socialismo. Se non si riannoda il
rapporto, il nesso di conseguenze, tra il già stato, il qui e il non ancora,
non si uscirà da questo purgatorio, in cui i lavoratori scontano le colpe dei
loro padroni e soprattutto di chi non li ha più contrastati» (p. 127). E se
l’«oltre» che evoca è ovviamente ancora molto nebuloso, è però chiaro quello
che deve essere il punto di partenza, il perno attorno al quale incardinare un
progetto politico, oltre che forse un argine contro l’emergenza antropologica.
Proprio al termine del saggio infatti scrive: «L’essere umano non può vivere
come appendice della merce, come funzione di mercato, come produttore di
reddito e consumatore del prodotto che produce. C’è un oltre di sé a cui
guardare, che, solo, può permettere il ritorno in te, attraverso la
coltivazione, educante, delle qualità generalmente umane. Questione
antropologica è lotta contro la disumanizzazione della vita da parte
dell’attuale organizzazione del mondo. L’agire politico, trasformativo, non può
ora che pensarsi e praticarsi in sintonia, in alleanza, con forme, libere, di
sensibilità religiosa. La dimensione laicista, la secolarizzazione dei
comportamenti alternativi, è ormai tutta catturata dentro l’orizzonte
invalicabile del presente. L’oltre della sinistra è invece l’oltre di questo
mondo. Questo linguaggio evocativo va riempito di contenuti, cioè di scelte,
decisioni, atteggiamenti, programmi, che parlino dell’esistenza quotidiana
delle persone semplici. Semplici è il nome politico, tradizionale, e proprio
per questo innovativo, per dire il concetto cristiano degli ultimi. Gli
esclusi, che non aspirano ad essere inclusi, piuttosto pretendono di escludere
da sé la subalternità, la dipendenza, la stessa acquiescenza, rispetto ai
meccanismi di sistema» (pp. 146-147).
Più che dal disinteresse, l’invocazione di Tronti è
stata accolta da una sostanzialità sordità, e forse anche questo testimonia
come l’«oltre» che affiorava da quelle righe sia ancora ben lontano dal
mostrare un profilo persino molto sfumato, e come le ultime posizioni del
filosofo romano si pongano trasversalmente rispetto alle direttrici del
progressismo novecentesco. Ma se la materializzazione di un orizzonte «oltre»
la sinistra novecentesca rimane per ora solo un auspicio, la realtà sembra
proporre uno scenario ben diverso. Ed è da questo punto di vista scontato che
molti abbiano visto nella linea seguita da Tronti negli ultimi due anni una
sorta di replica dell’atteggiamento più volte tenuto da Pietro Ingrao nel corso
della sua militanza all’interno del Pci. Impegnatosi con vigore come presidente
del Centro per la Riforma dello Stato in una battaglia politica di difesa del
«Lavoro» e della sua dignità politica, Tronti ha intravisto forse nel Pd
guidato da Pierluigi Bersani uno strumento per iniziare a dare consistenza al
progetto di una sinistra capace di andare «oltre» i suoi significati
novecenteschi. Ma, al di là di ogni valutazione sulla correttezza di quella
lettura, la storia è andata, come sappiamo, in un’altra direzione. E così
Tronti – nel suo nuovo ruolo di Senatore della Repubblica – ha spesso dovuto
anteporre la ‘novecentesca’ disciplina di partito alle proprie convinzioni,
piegandosi così alla forza del «nuovo che avanza». È per questo inevitabile che
più di qualcuno abbia individuato in questo atteggiamento ambivalente
l’ennesimo segno di quella sconfitta – politica e culturale – che Tronti
d’altronde inalbera orgogliosamente. Sebbene ogni valutazione politica possa
forse apparire oggi prematura, è però forse possibile leggere in una simile
sconfitta il segno del definitivo, irreversibile esaurimento storico di quella
sinistra italiana cui Tronti ha legato la propria vita, e non solo dal punto di
vista intellettuale.
In uno dei rari passaggi autobiografici che si
possono rinvenire nei suoi scritti, Tronti ha evocato un episodio risalente a più
di vent’anni fa, quando per la prima volta – fra il 1992 e il 1994 – aveva
occupato i banchi di Palazzo Madama. «Ero in Senato quando c’erano, per mia
fortuna insieme, Miglio e Bobbio. Sedevamo in disparte, a conversare, e Miglio
dice: sapete qual è una categoria fondamentale della politica? La vendetta.
Bobbio disse subito apertamente di no, io, in cuor mio, mi dissi, ma forse sì»
(ibi, p. 68). La questione dibattuta
allora dai tre intellettuali – che in qualche modo, rappresentavano tre
differenti declinazioni della tradizione del realismo politico italiano –
meriterebbe probabilmente un approfondimento, quantomeno per il posto che la
logica della vendetta ha sempre occupato nella storia nazionale. Ma non c’è
dubbio che Tronti sia tornato spesso col ricordo a quel dialogo, e alla
provocazione di Miglio. Gli eventi che abbiamo vissuto – e stiamo ancora oggi
vivendo – forniscono infatti ben più di qualche conferma all’idea secondo cui
la vendetta è davvero una delle categorie fondamentali della politica. Ma
confermano soprattutto che il nostro tempo non cessa ancora oggi di essere
permeato dalla vendetta. E che, anche per questo,
rimane ancora molto difficile, forse impossibile, intravedere cosa si nasconda
«oltre» la sinistra e «oltre» il Novecento. O persino capire se, dietro la
lunghissima coda del XX secolo, esista davvero un «oltre».




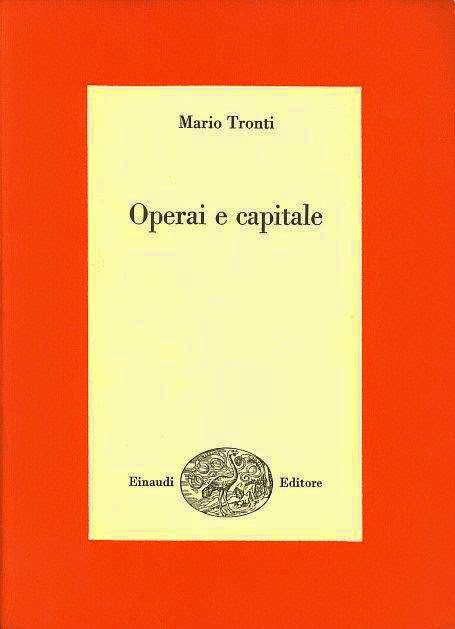



















.jpg)